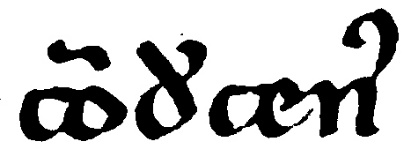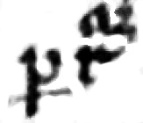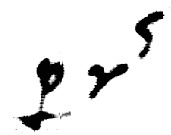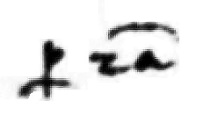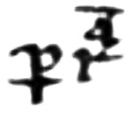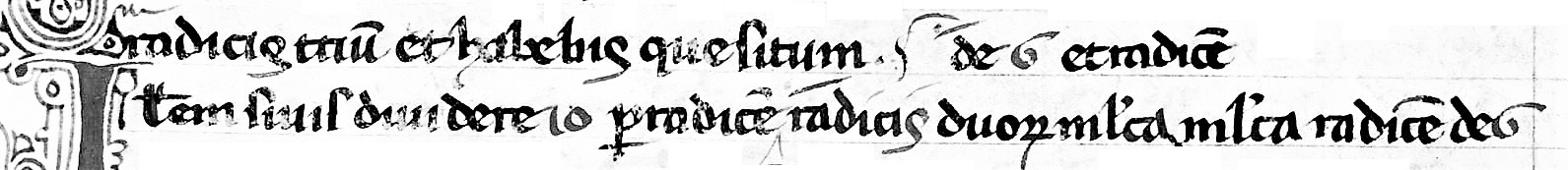Introduzione a LEONARDI BIGOLLI PISANI
Liber Abbaci, edidit E. Giusti adiuvante P. d'Alessandro,
Firenze: Olschki, 2020
Prima di procedere a raggruppare i manoscritti in famiglie,
osserviamo che
è
necessario distinguere tra i primi undici capitoli e quelli
successivi, e questo non solo perché
un gran numero di codici contengono solo in tutto o in parte gli
ultimi due o tre capitoli, ma anche perché
, come vedremo, un manoscritto può
appartenere a una famiglia per i primi capitoli e a un'altra per gli
ultimi.
Con questo avvertimento ben presente, esamineremo i vari manoscritti
in modo da individuare famiglie di codici con un antigrafo comune.
Un primo gruppo di manoscritti che mostra notevoli concordanze per
tutto il corso dell'opera
è
costituito dai codici
AGNV e
P,
quest'ultimo limitatamente ai capitoli 13-15 ‒ oltre
naturalmente a
B, copia dichiarata di
G
‒ tutti direttamente o indirettamente discendenti da un
subarchetipo
α, come dimostrano i numerosissimi
errores coniunctivi che li contraddistinguono, agevolmente
rintracciabili in apparato. Qui ci limiteremo a segnalarne qualche
esempio per ciascuno dei 15 capitoli:
(§ 1.9)
omissione di arcus;
(§ 1.14)
omissione di a decem;
(§ 2.57)
omissione di semper;
(§ 2.80)
que facit nonum gradum, et sic habetur summa dicte
multiplicationis] querit;
(§ 3.3)
omissione di etiam et trium;
(§ 3.21)
omissione di rebus;
(§ 4.9)
ponat, et 4 de 13: remanent 9 que ponat, et retineat] ponat
et retineat et 4 de 13 remanent 9 que ponat AGV et
retineat post 9 que ponat signo posito in marg. G2
ponat et retineat et 4 de 13 remanent 9 que ponat et
retineat N;
(§ 5.81)
remanent — (82) demonstrare] post (82) demonstrabimus;
(§ 5.83)
pro tertia parte] pro tamen (proinde A)
aperte;
(§ 6.22)
super 65] super ipsum 65;
(§ 6.60)
nimirum] numerum;
(§ 7.108)
divide per] pone super;
(§ 7.169)
invenimus] invenimus \({19 \over 53}\);
(§ 8.124)
dividere] adde;
(§ 8.134)
divides] divides in Alexandria (Alexandriam
GN);
(§ 9.44)
si] usi (corr. V2);
(§ 9.51)
omnes si] omnes AGV si
omnes N;
(§ 11.68)
de maiori mittes] mittes de maiori moneta;
(§ 11.69)
minori ... maiori ... si de maiori] maiori
(ex minori G) ... minori
(con F) ... si de minori;
(§ 12.51)
sumptionum] subscriptionum;
(§ 12.78)
provenit tetragonum EZ; ergo EZ equalis est] tetragonum
EZ (EC N) equalis;
(§ 12.113)
2050 per 100 et] 2500 (3550 N)
per bizantios 600 et;
(§ 13.68)
debebat dare] dabat;
(§ 13.130)
usuram] lucrum;
(§ 14.254)
cubus] summa (summe GNP)
proveniens (quod veniens AGNP venientes
s. lin. P2) ex (multiplicatione
post ex del. A) cubicatione;
(§ 14.289)
equatur duabus] habetur (bis G)
pro tribus (corr. P2);
(§ 15.14)
9 pro numero ED] 2 pro CD;
(§ 15.340)
ante quare] quare si comuniter auferatur 4 (4
om. A) census remanebunt census qui
equantur 4 censibus (censibus quat(t)uor GNP)
et denariis (del. V2).
Come si può
vedere, il testo di
α
è
caratterizzato da frequenti distrazioni da parte del copista,
che alterna omissioni
e trasposizioni nell'ordine delle parole
a varianti spesso adiafore e ad aggiunte inavvertitamente
suggeritegli dal contesto formulare e ripetitivo.
È
inoltre probabile che
α recasse accanto al
testo lezioni alternative e integrazioni. Si possono spiegare così
non soltanto le contraddittorie concordanze di
AV
contro
BGNP rell., di
BGNPV
contro
A rell. e di
ABGNP
contro
V rell., ma anche le saltuarie
coincidenze in errore di
α ora con
S,
ora con
H e
R, ora con
F
(o con
φ),
ai quali non sembra
accomunato da rapporti di parentela.
Anche l'epistola dedicatoria a Michele Scoto
(§ 1.2-6)
doveva essere riportata in margine da
α: in
tutti i suoi discendenti, infatti, l'intitolazione del
Liber
Abbaci (§ 1.1)
precede direttamente il prologo
(§ 1.7-10)
, mentre la lettera, del tutto omessa da
A e
rinviata dopo
(§ 1.10)
da
B,
è
appunto riprodotta in margine da
G, che per
l'occasione adotta un modulo di scrittura più
piccolo di quello del testo.
In questo caso
resta tuttavia il dubbio che la lettera si trovasse in margine già
in
ω, dal momento che
S la
riporta bensì
dopo l'intitolazione, ma poi omette il prologo, quasi che l'una fosse
destinata a sostituire l'altro.
Che del resto che il copista di
α abbia
riprodotto in margine, dove si trovavano nell'archetipo, almeno
(§ 2.26)
Superscripta — multiplicationes,
(§ 2.37)
Hucusque — transeamus e
(§ 2.56)
Nunc — ostendamus,
risulta
dimostrato dalla circostanza che i primi due passi sono tramandati da
AV ma non da
BGN e il terzo
unicamente da
A.
Che infine in
ABGN il capitolo 9 si interrompa al
paragrafo 101 e il testo riprenda poi dal capitolo 11,
mentre in
V manchino soltanto di
(§ 10.17)
sgg.,
potrebbe far pensare alla caduta
progressiva di due fascicoli in
α. Senonché
un'analoga lacuna, a partire dalle ultime parole di
(§ 9.102)
, si trova anche in due codici per il resto immuni dagli errori
distintivi della famiglia
α, cioè
HR, che insieme al cap. 10 omettono anche i primi 4
paragrafi del cap. 11.
In mancanza di altre significative
concordanze tra
αHR,
bisognerà
perciò
concludere che essi derivino da un archetipo ormai lacunoso e che
V
abbia ricavato l'ultima parte del cap. 9 e i primi paragrafi del cap.
10 da un manoscritto diverso dall'antigrafo altrimenti utilizzato.
Tra i vari codici della famiglia
α possiamo
identificare un certo numero di manoscritti che derivano direttamente
da
G. Di questi il primo
è
senza dubbio
B, che dichiaratamente risulta copiato
dal manoscritto fiorentino.
Un secondo manoscritto che deriva immediatamente da
G
è
N, che aggiunge un certo numero di errori propri
a quelli ereditati da
G,
di cui in qualche
caso fraintende le abbreviazioni:
(§ 2.3)
qualiter cordetenus in manibus multiplicentur.
G scrive
cordetenus in forma abbreviata e
con
c al posto di
t:
co(r)d(e)cen(us)
(fig. 1). Sia
B che
N leggono
cum
decenis.
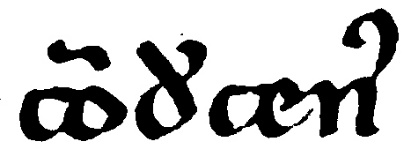
fig. 1
(§ 3.16)
quicquid procreatur ex eorum collectione est ex numero
tertii gradus, scilicet centenariorum.
Diversamente da tutti gli altri codici,
G scrive
est
numero, che
B ed
N correggono
congetturalmente in
est numerus.
(§ 5.53)
Alios vero primos qui sunt ultra centum per regulam
invenire docebo.
In
A e
V regulam
è
scritta
in extenso, mentre
FHRS usano una
forma contratta, una
r seguita o sormontata da
am (
ram
F,
rm H,
rā
R,
rā
S). Invece che
per regulam G
scrive una
p con asta tagliata (
per) sormontata da
ā (fig. 2), abituale abbreviazione per
personam.
A loro volta,
B ed
N interpretano
la
p con asta tagliata (
per) sormontata da
ā
come
postea.
Come il più
tardo
B, anche
N dimostra inoltre
di conoscere gli interventi correttivi apportati su
G
dalle mani posteriori:
(§ 5.81)
Sed ex diviso numero per 23 remanserunt 15, quibus
extractis de 13976, remanent 13961, quibus divisis per 23, veniunt
607; ergo ex multiplicatione de 23 in 607 proveniunt 13961. Quare
si multiplicatur proba de 607 que est 4 per probam de 23 que est 5,
veniunt 20, quorum proba, scilicet 2, est proba de 13961, quibus
additur proba de 15 que supersunt, que est 6: faciunt 8, scilicet
probam de 13976, et hoc volui demonstrare. Possunt enim
multiplicationes, additationes, minutiones seu divisiones numerorum
aliter per alias quasdam pensas probari, scilicet per eam de 7 et
de omnibus numeris hasam existentibus, ut per 11 vel per 13 et
deinceps. Quam doctrinam, secundum quod nobis videbitur congruum,
in sequentibus demonstrabimus.
Come ho già
detto, il testo da
remanent 13961 a
volui
demonstrare
è
spostato in
α dopo
demonstrabimus;
inoltre
α scrive
multiplicationis in
luogo di
multiplicationes e
73 in 607 anziché
23 in 607 (
23 corr.
V2).
In
G una mano posteriore ha corretto questi ultimi
due errori e ha aggiunto nel margine
erunt 13961 dopo
de
13976.
B e
N concordano con
α
nello spostare il testo, ma seguendo
G scrivono
multiplicationes,
23 in 607 e
erunt 13961 (
N) o
remanebunt
13961 (
B) dopo
de 13976.
(§ 5.82)
Possunt enim multiplicationes, additationes, minutiones
seu divisiones numerorum aliter per alias quasdam pensas probari.
Al posto di
quasdam G ha
quas dca
con
ca sormontate da trattino abbreviativo e
c
espunta, che una seconda mano corregge congetturalmente in
quam
dictas (fig. 3). Lo stesso
quam dictas si trova in
N. In questo caso
B ha
correttamente
quasdam.

fig. 3
(§ 7.77)
multiplica 12 per suam virgulam.
Come
è
stato osservato da C.
Carotenuto,
N ha invece
multiplica
ea 12 per suam virgulam, e Carotenuto commenta:
“
This singular lection might be induced in
N by the
copyist misreading of
F1 [il nostro
G]
where the writing of
«
multiplica
»
is ambiguous: in particular,
«
ca
»
may have been confused with
«
ea
»
from [leggi: by]
N
”
. Sempre da
G
è
stato copiato il codice
P, che contiene i capitoli
13-15.
Già
nel capitolo
13, oltre a vari errori particolari,
P
offre un gran numero di errori congiuntivi con
G,
tutti presenti anche in
N. Per esempio:
(§ 13.148)
Ex quibus si dederint tertio homini 11.
dederint manca sia in
G, che lascia uno
spazio (così
anche
N), che in
P senza spazio.
(§ 13.174)
minuunt bizantii \({4 \over 5} 12\) qui desunt ab
ipsis bizantiis \({1 \over 5} 17\) usque in 30
.
In luogo di
qui desunt G e i suoi
discendenti hanno
quinte sunt.
(§ 13.227)
ergo \({4 \over 5}\) partis cum \({2 \over 15}\) rei sunt
denarii \({1 \over 5} 16\)
.
G e i suoi discendenti hanno
ergo \({2
\over 15}\) partis cum \({1 \over 5} 16\)
.
(§ 13.324)
ergo \({9 \over 40}\) burse et \({51 \over 40}\) primi cum
\({19 \over 20}\) quarti sunt \({1 \over 2}\) primi et burse.
Questo passo
è
ripetuto in
G e nei suoi discendenti.
Nel capitolo successivo si trova un passo che prova che
P
è
una copia diretta di
G:
(§ 14.205-206)
... et habebis quesitum. Item si vis dividere 10 per
radicem de 6 et radicem radicis duorum ...
Qui
G salta dallo stesso allo stesso dimenticando
de
6 et radicem, e si corregge scrivendolo nella riga superiore dopo
et
habebis quesitum, ma leggermente separato e con un rimando appena
visibile dopo
per radicem (fig. 4).
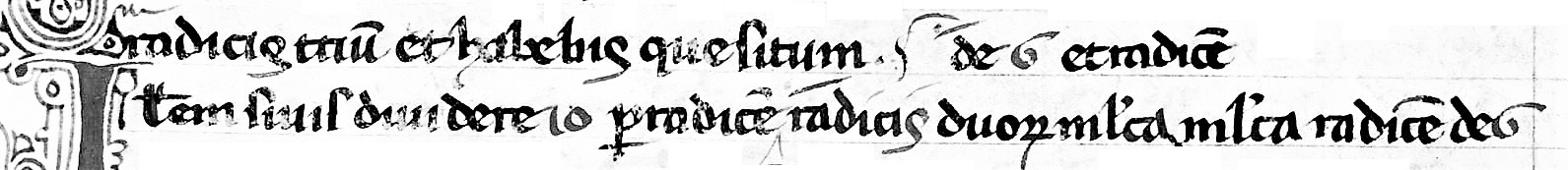
fig. 4
P non si accorge del segno e scrive
de 6 et
radicem subito dopo
et habebis quesitum, senza nessuno
spazio intermedio. Di conseguenza il passo in questione diventa in
P:
... et habebis quesitum de 6 et radicem. Item si
vis dividere 10 per radicem radicis duorum ...
In questo caso
N ha invece il testo corretto.
- 1 È questo uno dei non molti casi
in cui B corregge il proprio antigrafo.
- 2A sua volta S omette mittes,
aggiunto s. lin. da S2. In α
(che aggiunge moneta) la variante non si è prodotta
in seguito a un'omissione, ma è stata determinata dal
contesto, in cui ricorrono poco prima minori moneta e poco
dopo mittes de maiori.
- 3Sia B che N
correggono la dittografia.
- 4Vedi per es. in apparato a (§ 5.34)
6 et remanentia 2; (§ 5.57)
exeuntem; (§ 5.99)
et ponantur; (§ 7.67)
habet 9; (§ 7.87)
quia (dove α complica la
trasposizione di ita est dopo 3428 condivisa con
F); (§ 7.139)
divisis per; (§ 8.130)
multiplica tantum; (11.83) posita super;
(§ 11.133)
erunt 672, que; (§ 11.136)
erunt \({1 \over 2} 10\), que
; (§ 11.141)
nonas ... nonas; (§ 12.6)
dimidium ... dimidium; (§ 12.94)
superioris; (§ 12.233)
portione ... portione; (§ 12.247)
petitione; (§ 12.263)
est denariis 27; (§ 12.411)
coniunctionem; (§ 12.1293)
linee; (§ 13.265)
quintum; (§ 14.30)
quadratum multiplico ... multiplico; (§ 14.100)
multiplicare vis; (§ 14.124)
de 20 radicem de 80; (§ 14.143)
decompositi; (§ 14.178)
ex radice; (§ 14.200)
decomposita; (§ 14.233)
8 surgunt; (§ 14.242)
multiplicationes que provenerint duces; (§ 14.243)
superiorum; (§ 14.264)
sequentem; (§ 14.316)
Similiter cum; (§ 15.28)
sintque; (§ 15.56)
si; (§ 15.61)
multiplicatio; (§ 15.68)
summe; (§ 15.153)
posueris; (§ 15.285)
scis; (§ 15.439)
et radici; (§ 15.479)
multiplica hec; (§ 15.595)
intellectis. Frequenti le sviste nello scioglimento delle
abbreviazioni: vedi per es. a (§ 5.92)
posita super 7; (§ 5.112)
collocata; (§ 8.224)
tibi (prima di ex); (§ 12.67)
fient; (§ 13.145)
utique; (§ 13.121)
unoquoque; (§ 14.71)
unum; (§ 14.230)
coniunctis; (§ 14.297)
sicut; (§ 14.316)
ipsorum. Non meno rari gli errori nel riportare numeri e
frazioni: vedi a (§ 6.29)
de 36; (§ 6.108)
multiplica 4; (§ 7.67)
per 6; (§ 7.146)
in \(1 \text{ }\text{ }\text{ } 0 \over 10 \text{ }\text{
} 5\); (§ 7.173)
sunt \({1 \over 159}\); (§ 8.45)
9 et; (§ 8.96)
\({3 \over 4}\) 42; (11.90) \(\over 5 \text{ }\text{ } 103
\text{ }\text{ } 25 \text{ }\text{ } 12\); (§ 12.228)
iterum \({7 \over 8} 10\)
; (§ 12.488)
\({7 \over 120}\) primi; (§ 13.281)
\({1 \over 10}\) 5.
- 5Vedi ancora in apparato a (§ 5.1)
quoslibet numeros (dopo dividere); (§ 5.30)
ex divisione; (§ 5.53)
per numeros; (§ 5.98)
numeri; (§ 5.110)
de; (§ 5.128)
duarum; (§ 5.162)
dividat; (§ 6.2)
per facta minuta inferioris; (§ 6.40)
apertis; (§ 6.55)
dices (dopo \({2 \over 4}\)); (§ 6.62)
tabulis; (§ 6.93)
et adde (dopo 2); (§ 7.10)
\({5 \over 6}\); (§ 7.62)
sexte; (§ 7.128)
et per 7; (§ 7.158)
\({1 \over 11}\); (§ 8.77)
ea; (§ 8.149)
minor labor sit; (§ 8.150)
ergo (prima di rotuli); (§ 8.167)
cum; (§ 8.216)
sub; (§ 8.227)
multiplicabis (prima di 321); (§ 8.230)
cum; (§ 8.283)
erunt; (§ 8.285)
quod (dopo hoc); (§ 9.38)
\({1 \over 2}\); (§ 11.15)
uncie; (§ 11.73)
Et; (§ 11.103)
ex eis; (§ 11.111)
erunt 15; (§ 11.112)
erunt 5 ... erunt 12 ... erunt 21; (§ 11.133)
Item; (§ 11.134)
cum; (§ 11.165)
uncias; (§ 11.170)
partem; (§ 11.186)
semel ... semel; (§ 12.13)
quod totum per 44; (§ 12.13)
in libro; (§ 12.36)
numerum (dopo primum); (§ 12.50)
qualiter; (§ 12.64)
ut extractis; (§ 12.108)
de (dopo extrahe); (§ 12.119)
pone; (§ 12.134)
extremos; (§ 12.141)
vero; (§ 12.142)
e altrove hore; (§ 12.145)
diebus; (§ 12.179)
vero; (§ 12.194)
erit; (§ 12.203)
igitur; (§ 12.208)
e (§ 12.235)
pro; (§ 12.248)
modum; (§ 12.252)
autem; (§ 12.308)
est; (§ 12.313)
unius bizantii; (§ 12.346)
scilicet 1; (§ 12.347)
parte; (§ 12.347)
scilicet 1 per 1; (§ 12.368)
in se; (§ 12.438)
suprascripta; (§ 12.511)
homo; (§ 12.564)
per ordinem; (§ 12.589)
ipsum; (§ 12.667)
cum (prima di quartus); (§ 12.998)
paria (prima di 13); (§ 12.1295)
quandam; (§ 13.50)
ergo; (§ 13.60)
quem numerum; (§ 13.77)
denariis (prima di 7); (§ 13.102)
equi; (§ 13.156)
unam; (§ 13.158)
cum bursa (dopo secundus); (§ 13.244)
scilicet \({1 \over 10} 12\)
; (§ 13.289)
eorum; (§ 13.301)
tertii; (§ 14.82)
que sunt; (§ 14.92)
superficiem; (§ 14.136)
itaque linea; (§ 14.147)
linea; (§ 14.147)
primi; (§ 14.171)
numerus; (§ 14.176)
radicem (dopo multiplicare); (§ 14.178)
minus radice radicis de 15; (§ 14.180)
radicis (prima di trium, in fine paragrafo); (§ 14.199)
DB equalis quadrato linee; (§ 14.218)
et sic studeas — (§ 14.219)
nominis; (§ 14.221)
multiplicatio; (§ 14.223)
comunicans; (§ 14.230)
ex EB; (§ 14.230)
de (prima di 448); (§ 14.243)
figuram; (§ 14.243)
decene; (§ 14.244)
numeri; (§ 14.257)
cum sint numerus tertii; (§ 14.270)
primo; (§ 14.271)
quibus (dopo 56); (§ 14.281)
gradu; (§ 14.287)
radicibus; (§ 14.311)
predicta et a superficie; (§ 15.3)
primus ad BC; (§ 15.14)
multiplica; (§ 15.31)
ergo; (§ 15.37)
summa; (§ 15.50)
pars (dopo sicut); (§ 15.62)
5 pro numero; (§ 15.172)
ipsius (dopo diametro); (§ 15.343)
pars; (§ 15.475)
et \({1 \over 4}\); (§ 15.599)
\({1 \over 4} 1\)
; (§ 15.614)
et 4 (dopo 20).
- 6Vedi per es. in apparato a (§ 6.129)
proba per 7 est 0; (§ 7.48)
ea ad invicem; (§ 7.82)
-(§ 7.83)
per \({3 \over 4}\) 126; (§ 8.113)
summam per; (§ 8.125)
et de 2 sue sunt; (§ 11.3)
additione argenti; (§ 11.24)
\({1 \over 3}\) 8 alterius; (§ 11.39)
cum unciis 48 fuerint; (§ 11.63)
scire volueris (dopo autem); (§ 11.65)
facere vult; (§ 11.66)
habeat monetam; (§ 11.66)
super 9 pone; (§ 11.73)
exit eis aliquantulum; (§ 11.74)
scarsa moneta cum larga; (§ 11.74)
scarsa est; (§ 11.87)
maiores monetas; (§ 11.102)
proportione continua; (§ 11.133)
11 uncie; (§ 11.140)
Multiplica ergo; (§ 12.7)
colligere vis; (§ 12.21)
uno inde; (§ 12.71)
arborum regulis; (§ 12.86)
predicti numeri; (§ 12.90)
leo ille; (§ 12.93)
coniungentur se; (§ 12.107)
multiplicare oportuerat; (§ 12.134)
12 diebus; (§ 12.158)
\({1 \over 3}\) sui frumenti; (§ 12.168)
accipere eas; (§ 12.182)
fundi et cuperclii; (§ 12.200)
equalia addantur; (§ 12.315)
\({1 \over 3}\) et \({1 \over 4}\) et \({1 \over 5}\) et
\({1 \over 6}\) et \({1 \over 7}\); (§ 12.345)
quandam proportionem; (§ 12.367)
adde radicem eorum; (§ 12.419)
insimul iunge; (§ 12.504)
pretio equi; (§ 12.607)
et secundi hominis; (§ 12.665)
tantum dant; (§ 12.690)
velimus sanos omnes; (§ 12.712)
primam et secundam positionem; (§ 12.720)
solubilis; (§ 12.740)
de equis dicta sunt; (§ 12.741)
\({1 \over 4}\) reliquis; (§ 12.741)
secundum residuum; (§ 12.758)
pretium primi equi; (§ 12.1291)
retro virgulam; (§ 12.1296)
scias procedere; (§ 12.1316)
arboris regulas; (§ 13.47)
libris 4; (§ 13.83)
habeat; (§ 13.157)
quidem; (§ 13.161)
200 burse; (§ 13.168)
hac secunda particulari positione; (§ 13.234)
petit tertio et quarto homini; (§ 13.238)
prima particulari positione; (§ 13.255)
tertius homo; (§ 13.268)
superant; (§ 14.143)
radix quadrupli residui; (§ 14.248)
mille millene 44; (§ 14.259)
tertias, scilicet; (§ 14.262)
extracta cum; (§ 15.28)
et maiori numero; (§ 15.40)
Est enim; (§ 15.173)
dimidii diametri; (§ 15.300)
provenit est equale ei; (§ 15.306)
240 censu; (§ 15.317)
censo diminuto.
- 7Esempi di varianti a (§ 6.36)
nota; (§ 7.32)
describe; (§ 7.164)
exeunt \({8 \over 9}\) 2 (dove la sostituzione di exibunt
con l'analogo exeunt è complicata da un errore nel
numero); (§ 8.215)
ordinando; (§ 11.81)
scilicet differentiam; (§ 11.87)
adde; (§ 11.152)
descriptione ostenditur; (§ 12.14)
imitatur; (§ 12.115)
secundum suprascriptum modum; (§ 12.123)
veniant; (§ 12.298)
duxit; (§ 12.346)
e (§ 12.359)
Et si; (§ 12.423)
scilicet 3; (§ 12.468)
summa bizantiorum secundi; (§ 12.521)
de bizantiis; (§ 12.551)
Est igitur; (§ 12.675)
triplicatio; (§ 12.676)
querit; (§ 15.548)
equalis quadrato. Per le aggiunte vedi a (5.94) Post
hec copulet; (§ 7.108)
erunt; (§ 11.142)
quantum non; (§ 11.149)
namque; (§ 12.36)
ad sextum; (§ 12.36)
Inventis; (§ 12.53)
primi; (§ 12.88)
annis; (§ 12.166)
Primum; (§ 12.239)
Multiplicabis \({1 \over 6} 10\)
; (§ 12.327)
si hoc; (§ 12.362)
poteris; (§ 12.378)
ter tantum; (§ 12.667)
Quare; (§ 12.675)
tot; (§ 13.14)
residuum; (§ 13.251)
Pone; (§ 14.30)
est; (§ 14.127)
Ergo; (§ 14.128)
quod provenit; (§ 14.197)
maioris; (§ 14.241)
per probam (prima di de 56); (§ 14.303)
48; (§ 15.26)
Sit; (§ 15.383)
est; (§ 15.636)
Dimidia. Un caso notevole di dittografia a (§ 12.641)
Et.
- 8Su φ vedi oltre,
al § 11.
- 9In alcuni casi la concordanza potrebbe
derivare da note marginali presenti nell'archetipo. Vedi per
esempio (§ 12.986)
, dove nella tabella che accompagna il testo in margine, e che negli
altri manoscritti dice semplicemente numerus 119, α
(qui privo di V, che al solito omette le tabelle)
ha dopo 119 la frase cui si addideris 420 semel vel bis
vel quoties volueris habebis quesitum numerum, che non è
chiaro a cosa si riferisca. La stessa frase si trova in margine in
F, vicino al testo (987), ma senza un segno che
indichi dove debba essere collocata, ed è inserita nel testo
da R dopo le parole \({1 \over 10}\) \({1 \over
9}\) \({1 \over 8}\) \({1 \over 7}\) \({1 \over 6}\) \({1 \over
5}\) \({1 \over 4}\) \({1 \over 3}\) \({1 \over 2}\), mentre in H
sta alla fine del paragrafo dopo quantitate.
- 10Per evitare che perciò il testo
cominci ex abrupto con l'epistola dedicatoria, come di
fatto avviene in V, N
elabora un'intitolazione posticcia disposta su cinque righe a f. 3r:
Leonardus | filius Bonaccii | Pisani | Michaeli
Scotto | summo philosopho.
- 11Vedi supra, § 7.
- 12In A il capitolo 11
segue senza soluzione di continuità (§ 9.101)
introdotto soltanto dal titolo De moneta fienda (f. 34r).
In BGN, invece, il cap. 11 è privo di
qualunque intitolazione: B (f. 343r)
lo separa da (§ 9.101)
con una semplice linea bianca, mentre G (f. 88r)
e N (f. 101r) lo fanno iniziare a
pagina nuova.
- 13Dopo (§ 10.16)
V lascia bianco il resto del f 55r
(ultime 9 righe della prima colonna e tutta la seconda colonna) e
il f. 55v, per riprendere a scrivere dal f. 56r
introducendo il cap. 11 con la rubrica De consolamine
monete.
- 14A (§ 9.102)
quos pones H fa seguire immediatamente (§ 11.5)
Differentia prima sul medesimo f. 53r,
mentre R, lasciando bianca gran parte del f. 86r,
riprende la trascrizione di (§ 11.5)
a f. 87r.
- 15Non sembrano tali le seguenti: (4.7) que
sunt] qui sunt αHR;
(§ 5.40)
descripta] descripto αH
descripte R; (§ 5.66)
1085] 108 αHR;
(§ 6.16)
pensa 1] pensa 1 αHR;
(§ 7.42)
igitur] ergo αHR;
(§ 7.107)
multiplicare] quod non multiplica α
quod non multiplicabis R; (§ 7.152)
1] om. αHR; (§ 8.60)
deberemus] debemus αHR;
(§ 8.146)
Et ut] Sed (Set AG) ut
αHR; (§ 9.1)
in hoc] om. αHR; (§ 9.25)
sunt post] est post αHR;
(§ 9.34)
e altrove multiplica] multiplicabis αHR;
(§ 9.69)
notentur] supernotentur αHR,
ecc. Certamente casuali sono anche le banali coincidenze in errore
del solo R con uno o con l'altro dei discendenti
di α (più spesso con G),
riscontrabili dal confronto tra apparato e appendice.
- 16Lo conferma già la disposizione
dei paragrafi iniziali del primo capitolo. Poiché G
aveva copiato nel margine destro la lettera prefatoria a Michele
Scoto (1.2-6, omessi da A), B
l'ha inserita nel testo dopo i paragrafi proemiali (7-10). Non
molti i casi in cui B sana congetturalmente il
testo corrotto dell'antigrafo: per esempio (§ 5.46)
per 17 et per 19 BV] spatio relicto om. AGN;
(§ 11.175)
hec etiam B] h' omne AGV
hec omnia N; vedi anche supra,
note 1 e 3. A volte B conferma in margine che il
suo antigrafo aveva un'omissione o uno spazio bianco: ad esempio (§ 5.36)
virga de 4] 4 spatio relicto om. BGN
sic in c(odice) in marg. B; (§ 5.44)
super 5 et 0] spatio relicto om. BGN sic
in marg. B.
- 17Per non citarne che alcuni, (§ 1.8)
intellexi] incubui N; (§ 1.8)
suis] supradictis N; (§ 1.10)
deprecor] de peccato N; (§ 1.29)
septimo] septenario N; (§ 2.7)
econtra] etiam N; (§ 2.33)
20 vel 30] 20 per 30 N; (§ 2.39)
super tertium] similiter tertium N;
(§ 2.42)
superioris per 3] super 3 N; (§ 2.66)
duas figuras] duo figurae N; (§ 2.77)
factum] secundum N; (3.6) quod
est in inferiori numero] quod est inferior numerus
N; (3.14) multorum] multiplicatorum
N; (4.12) extractionum] actionum
N.
- 18Per esempio (§ 1.7)
stare voluit] ita est voluit G,
instrui voluit N (ita esse
voluit B); (§ 1.32)
296] septingenta nonaginta sex; (§ 1.33)
signa manuum] singula manu; (§ 2.17)
dele 9] dede 9; addis figuras] additis
figuris; (§ 2.25)
Utpote] Ut pare; (§ 2.26)
cernitur] oritur; (§ 2.35)
pro dicta] predicta; (§ 2.38)
universalem regulam] universalem regularem;
(§ 2.63)
sunt pensa summe multiplicationis] pro
pensa summe multiplicationis sunt, ecc. Si noti che a (§ 5.139)
N segue G scrivendo sit
10 in luogo di sit \({1 \over 10}\), sebbene
subito dopo corregga in per 10 l'erroneo per \({1
\over 10}\) di α. Invece a (§ 12.441)
480, scilicet, dove α legge 480
que, il numero diventa in G 8 480 (8
470 ante corr.) e in N 8480. Talora N
corregge o cerca di correggere congetturalmente il testo
dell'antigrafo (vedi (§ 8.149)
minor labor sit] in numero labor
sit α in numero labor sint G
in numero labores sint N), e in rari casi
riesce a sanare perfino errori risalenti all'archetipo: si veda per
esempio in apparato a (§ 12.469)
e (§ 12.1208)
; altre volte l'errore risaliva ad α: vedi per
esempio (§ 9.88)
vase N s. lin. B] vale
AGV ante corr. B; (§ 11.99)
maior N] om. α (ma
subito prima: tres sunt minores] minores tres
sunt BGN); (§ 12.308)
et eius N] eius α;
(§ 12.732)
secundi equi N] equi secundi α;
(§ 12.1318)
eandem proportionem] eadem proportione α
eamdem portionem N, ecc.
- 19A (§ 5.164)
dove α omette quot e G2
aggiunge in margine quod per poi depennarlo, N
riporta nel testo quod, ma lo sottolinea. A (§ 14.211)
dove α ha aliquod binomium per aliquod
trinomium, e G2 ripristina la lezione
giusta in interlinea, N scrive dapprima binomium
e poi corregge trinomium. Vedi anche il caso di (§ 4.9)
riportato sopra tra gli errori di α.
- 20Observations on selected
variants of Fibonacci's Liber Abaci. Reti Medievali Rivista, 14, 2
(2013), p. 187.
- 21(§ 13.1)
solvere] disolvere P; et
tamen] nunc P; (§ 13.7)
soldos 2 qui] secundum 2 quia P;
(§ 13.23)
cum numeri positionum] cum tales positiones P;
(§ 13.24)
positionum] earum P; (§ 13.30)
CF, scilicet] CF, similiter P;
(§ 13.62)
pro longitudine] per longitudinem per P;
(§ 13.71)
denarios] dictos P; (§ 13.83)
eam haberet] haberet bursam P; (§ 13.104)
equi, et] et P; (§ 13.114)
uno] numero P; (13.118) multiplica
bizantios] multiplica hi P; (§ 13.125)
duplica ter 12] duplicant P; (§ 13.160)
\({36 \over 313} 18\), qui sunt denarii \({30 \over
313} 15\)
] \({36 \over 113} 18\), qui simul denarii \({30 \over
113} 15\)
P; (§ 13.183)
veritati] unitati P; (§ 13.191)
positionem secundam] differentiam secundam P;
(§ 13.227)
secunda] prima P; (§ 13.268)
ut] cum P; (§ 13.338)
cuius] cum P.